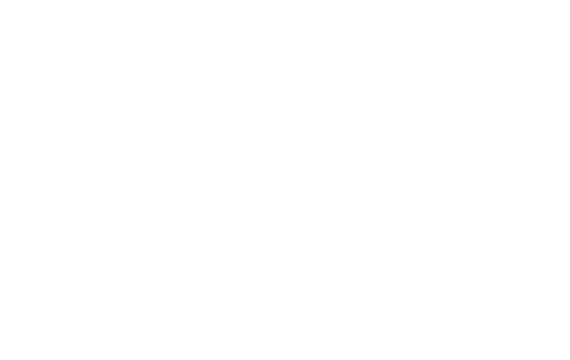Rododendri, Bocchette, Sienite: le tre vie dell'Oasi Zegna
Identità diverse che formano un unico, meraviglioso paesaggio naturale
- condividi su:
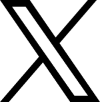
LA VIA DEI RODODENDRI
L’Oasi Zegna non è il giardino privato della famiglia Zegna,
come molti pensano. Né si paga un biglietto per entrare. Nemmeno “si entra”,
per la verità. È un meraviglioso spettacolo della natura, che è lì a
disposizione di chiunque voglia goderne, anche solo in automobile. Un’esplosione
di fiori e colori in mezzo alle montagne, specialmente tra maggio e giugno,
quando la Conca dei Rododendri, la prima scenografica via della Panoramica, dà
il meglio di sé. I rododendri in questione, che con la loro infinita varietà di
specie, forme e tonalità, danno il nome al primo tratto dell’Oasi Zegna, sono
originari dell’Himalaya, ma trovano qui, sulle pendici delle Alpi Biellesi, un
habitat ideale. “Per chi non ci è mai stato, la definirei come una valle un po’
erta, dura, ma che in un certo periodo dell’anno fiorisce tutta insieme. Una
grande pièce teatrale della natura”. Queste le parole dell’architetto Paolo
Pejrone, autore del recente intervento di ristrutturazione ambientale.
La Conca
dei Rododendri ha assunto la fisionomia attuale negli anni 60 grazie all’illustre
architetto paesaggista fiorentino Pietro Porcinai, che operò a Trivero tra il
1959 e il 1979. Figlio di un giardiniere, professionista stimato che veniva
definito da tutti “professore”, Porcinai entrò a far parte del processo di “disegno”
della montagna voluto da Ermenegildo Zegna, soprattutto per quanto concerne le
piantagioni. Progettò la Conca dei Rododendri direttamente sul terreno, senza
ricorrere a disegni in studio, diede le direttive per assestare adeguatamente
il suolo e fede disporre le piante in base alla loro dimensione e alle
differenti sfumature di colore, creando uno spazio verde aperto a tutti, un
vero e proprio giardino in mezzo alle montagne, che lascerà un ricordo
indelebile a chi si trova a visitarlo.
Porcinai è quindi l’uomo che per primo entra in punta di
piedi in questo ecosistema, lo modifica con rispetto senza stravolgere la sua
essenza. “Un nuovo ordine”, come amava ripetere l’architetto fiorentino, che
non si discostò dal paesaggio esistente né ebbe la pretesa di esprimere lo
stile del progettista né tanto meno del suo committente. A Trivero, Porcinai
trovò piuttosto un “laboratorio”: per lui questo grande giardino rappresentava
un punto di vista nuovo sul paesaggio, da non considerarsi come un progetto,
bensì come un processo in divenire, che un industriale visionario era stato
capace di riconoscere e valorizzare. In un momento in cui in Italia si pensava
a fuggire da quella stessa terra, l’architetto ritrova, tra i boschi piantati
da Ermenegildo Zegna, il senso stesso della profonda convinzione giovanile che
lo conduceva, già negli anni 30, sulle pagine di Domus, a titolare avventurosamente
uno dei suoi articoli: “La nazione intera deve essere un giardino”. Porcinai
analizzava e scomponeva chiedendosi: “Quali e quante piante sono presenti? In
che rapporto spaziale si trovano? Come si relazionano con gli ambienti
circostanti e con la morfologia del luogo?”. Lo faceva seguendo i dettami della
fitosociologia, la scienza che studia le relazioni all’interno delle comunità
vegetali.
“Con i nostri recenti interventi abbiamo tenuto assolutamente in
considerazione questo aspetto”, spiega oggi Pejrone. “Abbiamo piantato, per
esempio, un bosco di felci reali unico in un angolo che era un po’ abbandonato e
pieno d’acqua. Abbiamo inserito le piante giuste nei posti giusti, continuando
ciò che Porcinai aveva proposto”. Perché le piante non si aggregano mai
casualmente, ma in caratteristiche associazioni di specie in equilibrio fra
loro e con l’ambiente ospitante, che in questo caso, come sottolineava Pejrone,
“offre un microclima da valle dell’Himalaya con umidità costante, anche se
fredda: esattamente ciò di cui le piante necessitano”.
Prosegue l’architetto: “Il lavoro di Porcinai fu orientato
per donare all’ambiente un forte impatto estetico, prevedendo con lungimiranza
che queste piante avessero bisogno di meno cure possibili. E infatti per anni
gli interventi sono stati pochissimi e l’Oasi ha reagito benissimo perché era
stata progettata bene. Noi abbiamo cercato di fare un ulteriore salto di
qualità, soprattutto per quanto riguarda il tracciato interno di stradine,
pensato da Pietro Porcinai quasi esclusivamente per i giardinieri che dovevano
provvedere ai lavori di pulizia e manutenzione. Abbiamo reso invece le stradine
a misura di visitatore, pensando anche ai disabili che così oggi possono
entrare e farsi avvolgere dalla magia di questo bosco di rododendri in fiore”.
Pejrone è stato allievo di Russell Page, uno dei più grandi
architetti paesaggisti inglesi del ‘900. C’è qualcosa, nell’Oasi, in cui si
ritrova la lezione del maestro? “Certamente sì”, assicura l’architetto. “Si
rispecchia nel rigore dell’Oasi. Un successo come quello di Porcinai va
perseguito e alimentato senza paura di abbondare con le piante. Solo così si
può consegnare ai posteri qualcosa che sopravvive da sé. Non è un’impresa
difficile come costruire una torre di alberi in mezzo alla città.
È un processo
naturale, semplice, che appaga con il tempo, va seguito con leggerezza e non dà
lavoro, ma solo grandi risultati e soddisfazioni.
Oggi la coscienza
paesaggistica è più forte che un tempo. E l’Oasi Zegna è uno di quegli esempi
che dovrebbero essere tenuti in considerazione e presi a modello. Anche se
continua a essere un caso unico sull’intero territorio nazionale”. Come ama
ripetere Anna Zegna, “il paesaggio è il nostro presente ma anche la memoria del
nostro futuro perché ogni giorno con le nostre vite, anche inconsapevolmente,
lo plasmiamo”.
(Testo di Andrea Bertuzzi)
LA VIA DELLE BOCCHETTE
Gli atlanti stradali forniscono una versione distorta del
paesaggio. Dove non passa una strada c’è il nulla. Uno spazio vuoto che
qualcuno accomuna a un luogo selvaggio. Ma in un Paese come l’Italia la
semplice idea che una zona selvaggia sia priva di storia e di vestigia del
passato è sbagliata e inadeguata. Non rende giustizia alle persone che hanno
attraversato queste zone, alla natura che silenziosa le invade e alla
connessione di uomo e natura nel creare un ambiente unico e assai vivido. L’alta
Valsessera in questo senso è un luogo emblematico. Non ci sono strade, eccezion
fatta per qualche tracciato forestale chiuso al traffico. Non ci vive più
nessuno, tranne sparuti pastori durante la bella stagione e sciatori in
inverno. Eppure è un luogo bellissimo. Una valle impervia e densa, dove
passeggiare per ore sfruttando la fitta rete di sentieri che sale e scende,
toccando alpeggi, antiche miniere, punti panoramici e piste da sci.
Per raggiungerla la via migliore è prendere una strada:
percorrendo la Panoramica Zegna nel suo tratto più alto, fermandosi a Bocchetto
Sessera (per chi arriva da Biella), oppure alla Bocchetta di Margosio (per chi
sale da Trivero), e poi da qui iniziare a camminare, lasciandosi andare a una
natura severa e abbondante. Una wilderness apparente: perché se si guardano le
fitte faggete della Valsessera si è portati a pensare sia un territorio
naturale, invece è altamente influenzato dalla mano dell’uomo, che nei secoli
ha disegnato il paesaggio, neanche fosse una collina toscana. Ha abbattuto foreste
per farne pascoli; aperto strade e sentieri; costruito ponti e scavato miniere.
Dal XII secolo la valle è un vero monumento storico e
ambientale, strettamente legato allo sviluppo dell’industria biellese. Questo
perché da qui venivano la lana per la tessitura, la legna per il carbone
vegetale che metteva in moto le macchine a vapore e anche l’acqua per le
industrie del fondovalle.
Per avere una prima visione d’insieme di questo mondo
selvaggio ma a suo modo profondamente antropizzato basta un’escursione lungo
quella che è conosciuta come Via delle Bocchette. Si può decidere di seguire il
sentiero F7/F3, ben battuto e mai difficile, che si mantiene appena sotto la
costa e unisce Bocchetta Margosio con Bocchetto Sessera, passando da Bocchetta
di Luvera, poi sotto la rocca d’Argimonia (la rocca più impervia di questo
versante della valle) e dall’Alpe Moncerchio.
In corrispondenza delle Bocchette (l’equivalente dei passi
da cui si transitava tra una vallata e l’altra) si trovano locande dove sostare
e cartelli che raccontano con dovizia di particolari il panorama che si apre davanti,
in modo da leggere il paesaggio con un minimo di cognizione geografica. E, a
sapere anche di geologia, si scoprirebbe che la valle è tagliata in due dalla
linea insubrica, la faglia che a livello geologico rappresenta il confine
ideale tra il continente africano e la massa euroasiatica.
Dall’alto delle Bocchette,
in una giornata di cielo terso e leggero dal lato della Valsessera lo sguardo
arriva fino a contemplare la mole imponente del Monte Rosa con le sue 24 punte
oltre i 4mila metri.
Sapendo bene dove guardare si vede anche Capanna Margherita,
mentre più a oriente la scena è chiusa dalle vette del massiccio del Mischabel,
interamente in territorio svizzero. La vista è maestosa, soprattutto dalla
Bocchetta di Margosio, che domina l’alpeggio sottostante. Qui si trova una
delle poche malghe ancora in servizio in questa parte della valle. Nelle altre
il bosco ha invaso i prati e si è ripreso quel che gli era stato tolto.
E dire
che un tempo, prima del boom del tessile, gli alpeggi erano oltre 150. Per
tutto il periodo estivo qui vivevano centinaia di persone: gli alpigiani con le
loro famiglie, i carbonai, i minatori, i boscaioli. Ora gli alpeggi sono giusto
una manciata, ma molto attivi. L’Alpe Margosio è una delle cellule dell’ecomuseo
biellese, un luogo dove assaggiare formaggio di capra e approfondire il lato
umano della vita in alpeggio.
Non ci sono alpeggi invece vicino alla Bocchetta di Luvera,
che deve il nome al passaggio dei lupi, che qui venivano cacciati con il metodo
della “luera”, ovvero una grande buca coperta di frasche in cui si cercava di
intrappolare i lupi attirandoli con delle esche. Un metodo antico, che qui come
in altre zone delle Alpi ha funzionato, visto che il lupo per decenni è
scomparso. Adesso pare che nella zona ne circoli uno solitario che di tanto in tanto
ulula qua e là, ma è una presenza discreta. Come discreti sono i grandi mammiferi,
camosci, caprioli e qualche cervo che popolano le solitudini della valle.
Un
altro alpeggio (in questo ci si può anche fermare per la notte) si trova all’alpe
Moncerchio, sotto le piste da sci e gli impianti di risalita che da Bielmonte
salgono al monte Moncerchio e scendono il Valsessera. Si arriva a piedi in meno
di un’ora seguendo un sentiero ampio e quasi senza dislivello, attraversando l’area
di rimboschimento dove si concentra il Carabus Olympiae, il coleottero endemico
delle Alpi Biellesi divenuto simbolo dell’Oasi. Coleottero dalle abitudini
notturne che convive in tranquillità con le Pezzate rosse, le mucche tipiche
della zona, i cui campanacci un tempo movimentavano il silenzio della valle e
oggi sono il segnale sonoro della sopravvivenza degli antichi mestieri.
Non sono sopravvissuti invece i mestieri legati alla dura
vita di miniera. Perché se è vero che raggiungere un luogo selvaggio significa
in realtà inoltrarsi nella storia umana, è altrettanto vero che molte delle
testimonianze del passato sono evaporate come vecchio inchiostro. È il caso
dell’attività mineraria che per secoli ha segnato la vita della parte alta
della valle, quella chiusa a Occidente dal Monte Bo, che con i suoi 2.556 metri
è la cima più alta della zona. Ferro, piombo, argento: con alterne fortune
opifici e miniere sono stati attivi per secoli. Oggi per scoprire l’archeologia
proto-industriale che rientra nel geo-parco minerario dell’alta Valsessera ci
sono quattro anelli che partono da Bocchetto Sessera o da Artignano.
Sentieri
ben segnalati, attrezzati con ponti tibetani che permettono fi guadare i
torrenti, ricchi di tavole informative si inoltrano in zone che già nei
toponimi portano impressa la loro storia: Pietra Bianca, Rondoliere,
Argentiera. In alcune parti, come ad Argentiera superiore, si vedono ancora i
cunicoli con le armature in legno dove si introducevano i minatori per andare a
scavare la montagna. Altrove ci si imbatte nei resti di un altoforno del 1788
dove si produceva ghisa e si realizzavano prodotti per l’agricoltura; vanghe,
asce, zappe. Frammenti di storie che emergono dal paesaggio, altro che nulla, gli
spazi senza contorni di cui fantastica la natura selvaggia.
(Testo di Tino Mantarro)
LA VIA DELLA SIENITE
C’è un che di severo nella parte più occidentale della
Panoramica Zegna. Da Bocchetto Sessera la strada attraversa o grandi pascoli
fioriti di Monticchio e poi scende piano piano verso la Valle del Cervo, con i
suoi piccoli borghi in pietra, graziosi e solitari. Davanti si apre una
montagna aspra e spigolosa, geologicamente modellata dall’agire delle acque e
dal ritirarsi dei manti glaciali. La vegetazione, un tempo controllata e rada
specie intorno agli agglomerati di baite, dove gli alberi lasciano spazio alle
coltivazioni e allo sfalcio dell’erba, oggi è densa come non mai. I crinali
sono ricoperti di un bosco fitto fitto: qualche castagno, molti faggi, tante
betulle. Betulle che hanno invaso pascoli in disuso, perché la montagna si è
spopolata anche qui. La fabbrica in pianura attira più della stalla, lo
stipendio a fine mese più dell’incertezza della libertà.
E così l’antropizzazione batte in ritirata, la natura
inesorabilmente anno dopo anno colonizza di nuovo tutto quel che l’uomo
dimentica. Rimane, quello sì, un fitto reticolo di mulattiere, gradonate e
acciottolate, in genere a mezza costa, sostenute da muretti a secco costruite
nei secoli da mani sapienti per unire i diversi cantoni dell’alta Valle del
Cervo.
Montagna dura, questa. Come è dura la sienite, roccia intrusiva estratta
in grandi quantità dalle cave di Quittengo, San Paolo Cervo e Rosazza. Pietra
resistente all’usura e agli agenti atmosferici, particolarmente adatta all’utilizzo
nelle costruzioni, ma anche un eccellente materiale da decorazione, specie per
la sua tinta scura largamente adoperata per i monumenti funebri. Pietra che
caratterizza il paesaggio di questa parte alta della Valle di Andorno, nome che
un tempo denominava tutta la Valle del Cervo a Nord di Biella. Così gli uomini
di queste contrade hanno sempre abbinato le due professioni di scalpellino e
muratore. Sapevano sbozzare e rifinire i blocchi di pietra squadrata, ma erano
anche grandi mastri muratori, ricercati in tutta Europa. Fin dal ‘700, alcuni
dei più capaci si fecero apprezzare nella realizzazione di fortificazioni in Piemonte
e Savoia. E durante l’impero di Napoleone imprese associate di Rosazza vinsero
appalti e costruirono le strade di valico del Moncenisio e del Sempione.
La
ricchezza del tessile era là da venire e andavano a cercare fortuna lontano
dalla valle.
Lasciavano la Bürsch, la casa o la “piccola patria” nella
parlata dialettale locale. Il centro di gravità permanente della vita di chi
era cresciuto nelle terre dure dell’alta Valle del Cervo, il cui versante
orientale ricade all’interno dell’Oasi. Ci sono diversi minuscoli borghi in
pietra in questo versante, nuclei di baite un tempo densamente abitate. Come il
soleggiato Sassaia, arroccato tra i boschi, raggiungibile con una stradina irta
e stretta. Sono grigi, scuri, raggrumati con le abitazioni antiche ben
sistemate che si sorreggono l’un l’altra, così come una volta si sorreggevano
le persone che ci vivevano. In particolare le donne, che in inverno restavano sole
nel paese a portare avanti la famiglia, a tessera e a badare agli animali.
Come sempre in montagna, qui le persone per sopravvivere
avevano dato un significato vero alla parola comunità. Così anche i giochi
erano comunitari, lo si legge sulle pietre tra le viuzze di Forgnengo.
Su
diversi massi di sienite grandi e lisci sono stati incisi giochi di società. Si
tratta dello schema del gioco dell’orso, una tradizione scomparsa dalla Valle
del Cervo, in cui tre cacciatori in quaranta mosse dovevano catturare l’orso
prima che si desse alla macchia. Orso che nono vive più in queste valli da
decenni e non ha ancora fatto ritorno, come invece è accaduto in altre zone
delle Alpi.
È un bel paesaggio quel che si osserva in questo lato
occidentale dell’Oasi, diverso, più alpino e remoto rispetto a Trivero. Per
goderlo appieno è d’obbligo fermarsi a Poggio Bruera. Tra gli alberi, una
tavola d’insieme spiega il panorama che si dispiega sull’alta Valle del Cervo.
Di fronte, a mezza costa, la figura massiccia dell’ospizio seicentesco di S.
Giovanni. In alto, evidenti come graffi nella pelle, le due cave di sienite
ancora attive. Qui la roccia che ha segnato la storia di uomini e paesi della
valle ormai si estrae soltanto; la lavorazione avviene lontano, altrove, fuori
dalle montagne. Sotto, sparsi si vedono paesi, frazioni e borgate con bei nomi
antichi: Oretto, Mazzucchetti, Quittengo, Mortigliengo, Bariola, Piaro. Ammassi
di case grigie con tetti grigi, qui e lì qualche tocco di bianco a ravvivare l’insieme.
Abiti raggrumati, perché in inverno il freddo è meno freddo se le pareti sono
addossate le une alle altre.
Nel fondovalle si srotola il nastro della statale 100 che
sale da Biella e a Valmosca si unisce alla Panoramica Zegna, segnando il
confine dell’Oasi. La strada tocca la stupefacente Rosazza, meno di cento
abitanti, una nobile architettura ottocentesca legata al senatore biellese
Federico Rosazza e all’architetto Giuseppe Maffei che edificò gran parte del borgo.
Qui si trova un piccolo museo etnografico che racconta la vita all’interno
della Bürsch. È una cellula dell’Ecomuseo del Biellese, che racconta com’era la
vita nella zona prima dell’arrivo dell’industria tessile. La strada poi conduce
a Piedicavallo, altro paese da duecento abitanti e un’unica acciottolata via centrale,
via Roma. Qui la valle si chiude e si arriva al capolinea, a meno di non iniziare
a scalare con l’agilità del camoscio e andare a vedere se di là, in Valsesia e
in Val d’Aosta, è meglio.
(Testo di Tommaso Gambini)